Azitromicina nel trattamento delle infezioni respiratorie

La pandemia ha portato l’attenzione dell’opinione pubblica, degli operatori sanitari e dei decisori sulle infezioni respiratorie e sul loro trattamento.
Le infezioni respiratorie rappresentano un variegato gruppo di quadri clinici (rinosinusiti, faringiti, laringiti, bronchiti, polmoniti) caratterizzati da sintomatologia a carico delle alte o basse vie dell’apparato respiratorio e causati da differenti agenti eziologici (soprattutto virus e batteri) (1). Tali infezioni sono una delle principali cause di morbosità e mortalità in tutto il mondo (2). Infatti, queste patologie sono ubiquitarie, colpiscono individui di tutte le età e di entrambi i sessi. L’organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha stimato che la mortalità mondiale per infezioni respiratorie sia stata di circa 3 milioni di individui nel 2019 (3). Molteplici fattori concorrono nel favorire l'elevata frequenza delle infezioni respiratorie: la numerosità degli agenti eziologici, la loro diffusione, la breve durata dell’immunità conseguente alla patologia. La scarsa immunogenicità della maggior parte dei patogeni coinvolti nelle infezioni respiratorie o le loro caratteristiche mutazionali determinano infatti una breve durata dell’immunità acquisita, ed è per questo motivo che nel corso della vita sono possibili reinfezioni da parte dello stesso agente eziologico. A fronte di quanto sopra descritto, rappresentando i batteri un agente eziologico primario o susseguente/concomitante ad un’infezione virale, la ricerca farmacologica si è orientata allo sviluppo di antibiotici efficaci, ad ampio spettro, sicuri, con schemi terapeutici semplificati. I macrolidi rappresentano da circa 70 anni uno strumento terapeutico importante. L’Eritromicina, isolata nel 1952 dal batterio Streptomyces erythraeus, sebbene avesse un’eccellente attività antibatterica, presentava scarsa biodisponibilità, bassa stabilità a pH acido e farmacocinetica poco predittibile. Ciò ha indotto a sviluppare una seconda generazione di macrolidi: l’azitromicina è dunque un derivato semisintetico dell’eritromicina (4) dotata di maggiore biodisponibilità (35-42%) (5) ed emivita plasmatica tale da garantire la monosomministrazione per os (4). Inoltre l’azitromicina presenta un’aumentata capacità di penetrazione nei tessuti (MIC 90 dopo singola dose orale di 500 mg) (5) grazie alla sua alta lipofilia, risultando più efficace nel trattamento delle infezioni da patogeni intracellulari come l’Haemophilus Influenzae.
In merito alla sicurezza d’impiego è opportuno ricordare che azitromicina non si lega al citocromo P450 3A4 ed è inserita dall’FDA tra i farmaci di categoria B1 in gravidanza (5). L'OMS ha inserito l’azitromicina tra i farmaci più sicuri (6) ma è bene ricordare che non è indicata in pazienti con intervallo QT prolungato o in associazione a farmaci che lo prolunghino. A riprova della sua efficacia e sicurezza basti pensare che nel solo 2017 è stata prescritta negli US 12 milioni di volte (7). In considerazione dell’elevato numero di studi condotti sull’utilizzo di azitromicina nelle infezioni respiratorie, sono attualmente disponibili numerose metanalisi sul tema, anche focalizzate su specifiche popolazioni. Ad esempio, l’analisi di Laopaiboon su 15 trials, che hanno coinvolto 2496 pazienti, non ha evidenziato differenze significative nel fallimento terapeutico di infezioni del tratto respiratorio tra azitromicina e amoxicillina o amoxicillina/clavulanato, mentre l’azitromicina sembra più efficace nel trattamento delle bronchiti acute (8). Anche l’utilizzo a lungo termine di azitromicina nel paziente con bronchiectasie non correlate a fibrosi cistica si è dimostrato efficace nel ridurre la frequenza delle riacutizzazioni e nel migliorare la qualità della vita (9). Allo stesso modo, dati significativi arrivano dall’utilizzo per 6 mesi di azitromicina nei pazienti con fibrosi cistica (10).
È indubbio che l’azitromicina rappresenti un prezioso strumento terapeutico per il trattamento della patologia infettiva delle vie aree superiori ed inferiori. In quanto tale il suo utilizzo deve essere basato sull’appropriatezza prescrittiva al fine di evitare fallimenti terapeutici, effetti avversi, insorgenza di resistenze batteriche. Dopo 42 anni dalla sua sintesi, gli studi sul suo utilizzo in acuto ed in cronico ne fanno una protagonista per il presente e per il futuro.
A cura di
Prof. Fulvio Braido
Università degli Studi di Genova
Responsabile UOSD di Pneumologia per la continuità assistenziale ospedale territorio
Ospedale Policlinico IRCCS San Martino – Genova.
Cod. TRO-2022-015
Bibliografia
- World Health Organization. Acute respiratory infections. 1990. https://apps.who.int/iris/handle/10665/61939
- GBD 2016 Lower Respiratory Infections Collaborators. Estimates of the global, regional, and national morbidity, mortality, and aetiologies of lower respiratory infections in 195 countries, 1990-2016: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2016. Lancet Infect Dis. 2018 Nov;18(11):1191-1210. doi: 10.1016/S1473-3099(18)30310-4. Epub 2018 Sep 19. PMID: 30243584; PMCID: PMC62024439.
- https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/the-top-10-causes-of-death
- Dinos GP. The macrolide antibiotic renaissance. Br J Pharmacol. 2017 Sep;174(18):2967-2983. doi: 10.1111/bph.13936. Epub 2017 Aug 10. PMID: 28664582; PMCID: PMC5573421.
- McMullan BJ, Mostaghim M. Prescribing azithromycin. Aust Prescr. 2015 Jun;38(3):87-9. doi: 10.18773/austprescr.2015.030. Epub 2015 Jun 1. PMID: 26648627; PMCID: PMC4653965).
- World Health Organization Model List of Essential Medicines: 21st List, World Health Organization, Geneva, 2019 hdl:10665/325771.
- Firth A, Prathapan P. Azithromycin: The First Broad-spectrum Therapeutic. Eur J Med Chem. 2020 Dec 1;207:112739. doi: 10.1016/j.ejmech.2020.112739. Epub 2020 Aug 19. PMID: 32871342; PMCID: PMC7434625
- Laopaiboon M, Panpanich R, Swa Mya K. Azithromycin for acute lower respiratory tract infections. Cochrane Database Syst Rev. 2015 Mar 8;2015(3):CD001954. doi: 10.1002/14651858.CD001954.pub4. PMID: 25749735; PMCID: PMC6956663).
- Kelly C, Chalmers JD, Crossingham I, Relph N, Felix LM, Evans DJ, Milan SJ, Spencer S. Macrolide antibiotics for bronchiectasis. Cochrane Database Syst Rev. 2018 Mar 15;3(3):CD012406. doi: 10.1002/14651858.CD012406.pub2. PMID: 29543980; PMCID: PMC6494352).
- Southern KW, Barker PM, Solis-Moya A, Patel L. Macrolide antibiotics for cystic fibrosis. Cochrane Database Syst Rev. 2012 Nov 14;11(11):CD002203. doi: 10.1002/14651858.CD002203.pub4. PMID: 23152214; PMCID: PMC7098459).
I Correlati
L'influenza sarà impegnativa: indispensabili le vaccinazioni, il ruolo del medico di famiglia
Nicastri e Vairo dello Spallanzani. "A fine 2023 abbiamo visto un boom di contagi influenzali che si sono sommati al Covid e al virus respiratorio sinciziale (Rsv). I decessi toglieranno dalla cartina una città con 20mila abitanti"
Ema: parere positivo per il vaccino anti-Rsv in 50-59enni a maggior rischio infezione
Gsk, se approvato a settembre, sarà il primo contro virus respiratorio sinciziale con questa indicazione in Europa
Virus sinciziale, le linee guida del ministero della Salute per la prevenzione
"E' la prima causa di bronchiolite e quindi di ospedalizzazione nei bambini sotto l'anno di vita, di infezioni respiratorie acute e di bronchite asmatica in bambini, adolescenti e giovani adulti". I pediatri di famiglia della FIMP pronti a fare la pr
Lattoferrina, studio dimostra che riduce del 50% le infezioni respiratorie nei bambini in età prescolare
I risultati confermano il ruolo benefico della lattoferrina contro i virus responsabili delle comuni infezioni respiratorie stagionali
Ti potrebbero interessare
L'influenza sarà impegnativa: indispensabili le vaccinazioni, il ruolo del medico di famiglia
Nicastri e Vairo dello Spallanzani. "A fine 2023 abbiamo visto un boom di contagi influenzali che si sono sommati al Covid e al virus respiratorio sinciziale (Rsv). I decessi toglieranno dalla cartina una città con 20mila abitanti"
Ema: parere positivo per il vaccino anti-Rsv in 50-59enni a maggior rischio infezione
Gsk, se approvato a settembre, sarà il primo contro virus respiratorio sinciziale con questa indicazione in Europa
Virus sinciziale, le linee guida del ministero della Salute per la prevenzione
"E' la prima causa di bronchiolite e quindi di ospedalizzazione nei bambini sotto l'anno di vita, di infezioni respiratorie acute e di bronchite asmatica in bambini, adolescenti e giovani adulti". I pediatri di famiglia della FIMP pronti a fare la pr
Lattoferrina, studio dimostra che riduce del 50% le infezioni respiratorie nei bambini in età prescolare
I risultati confermano il ruolo benefico della lattoferrina contro i virus responsabili delle comuni infezioni respiratorie stagionali



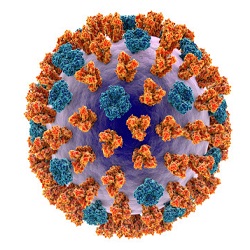
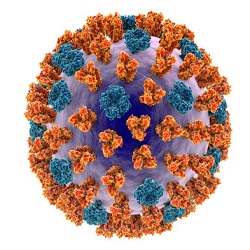


Commenti